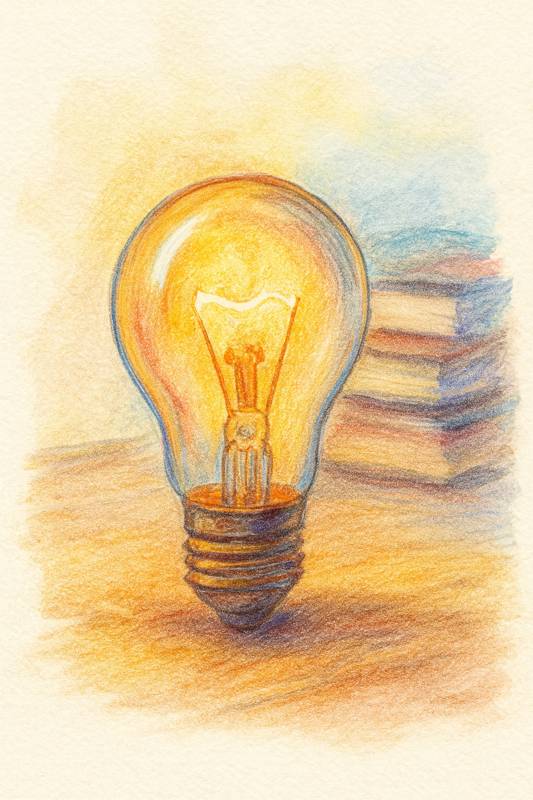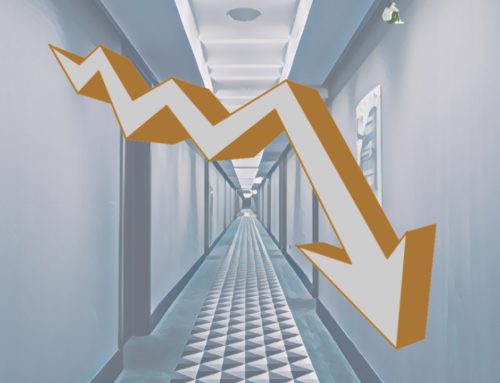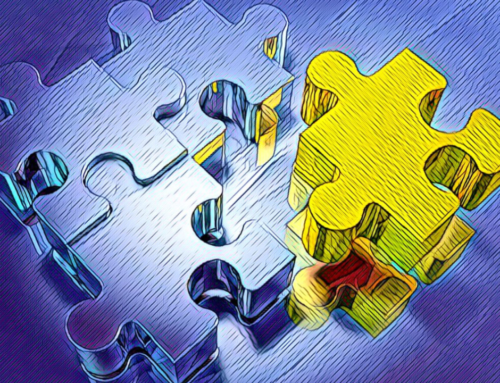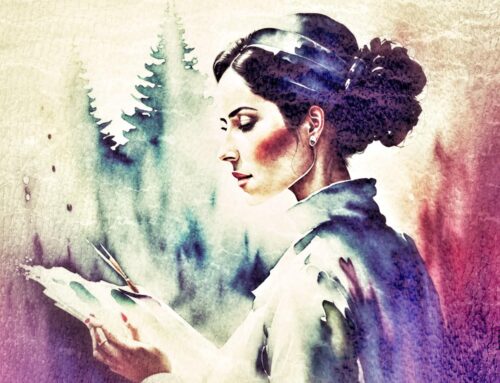MA QUANTE MEMORIE ABBIAMO?
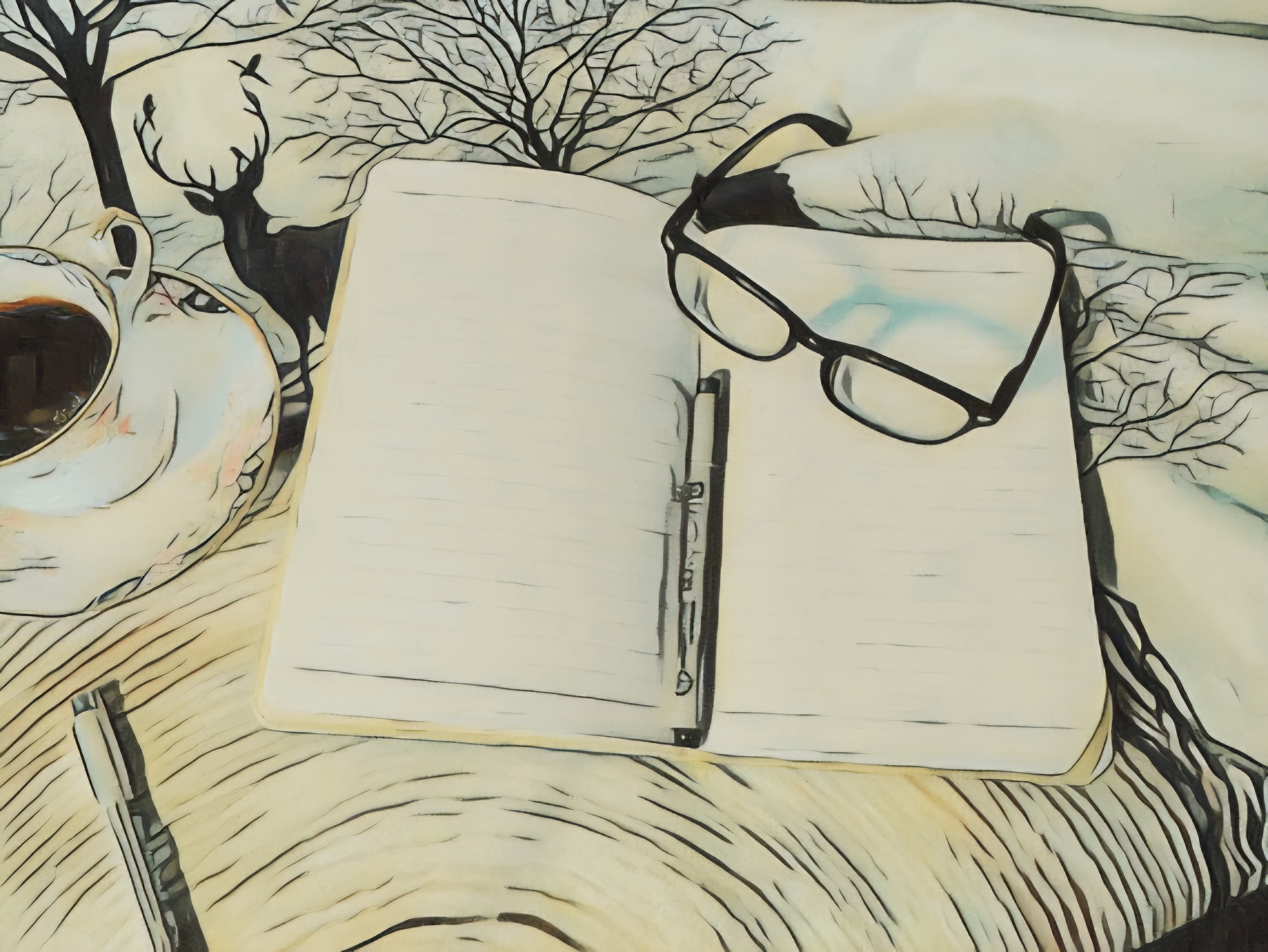
Ultimamente, durante le sessioni di coaching, mi sono accorta di una cosa curiosa sui diversi tipi di memoria: pur avendo una memoria che definirei piuttosto ballerina, ogni volta che incontro una coachee — anche a distanza di anni — mi riaffiorano dettagli che pensavo dimenticati. È come se la loro presenza davanti a me fosse una chiave che apre cassetti chiusi da tempo.
Questo mi ha fatto riflettere su quanti tipi di memoria convivano dentro di noi e come influenzino le nostre relazioni e i nostri ricordi quotidiani.
Mi sono chiesta: ma quante memorie abbiamo davvero?
Spesso pensiamo alla memoria come a un contenitore unico, ma la realtà è più complessa e, per certi versi, affascinante. I tipi di memoria si possono distinguere non solo in base al tempo in cui trattengono le informazioni — breve o lungo —, ma anche in base al modo in cui custodiscono ciò che viviamo: alcune sono consapevoli e descrivibili, altre più sottili e inconsapevoli, ma non per questo meno potenti.
La memoria più immediata e fragile è quella a breve termine, o memoria di lavoro: una sorta di appoggio temporaneo che ci consente di trattenere poche informazioni per pochi secondi o minuti. È quella che usiamo, per esempio, quando memorizziamo al volo un numero di telefono appena ascoltato o il nome di una persona durante una presentazione.
Poi c’è la memoria a lungo termine, il grande archivio dove le informazioni possono rimanere per ore, giorni, anni o persino tutta la vita. Questi sono tra i tipi di memoria più conosciuti, ma esistono molte altre forme più sottili e spesso inconsapevoli.
Una parte importante è la memoria esplicita, quella che possiamo richiamare consapevolmente. Comprende la memoria episodica — i ricordi personali, come il primo incontro con una cliente o un viaggio particolarmente significativo — e la memoria semantica, che raccoglie conoscenze generali e fatti: sapere, ad esempio, che Barcellona è in Spagna o che l’acqua bolle a cento gradi.
C’è però anche un altro tipo di memoria, più sottile e meno visibile, chiamata implicita. È quella che guida molte delle nostre azioni quotidiane senza che ce ne accorgiamo. Pensiamo alla memoria procedurale: le abilità che abbiamo interiorizzato, come andare in bicicletta o condurre una sessione di coaching senza doverci concentrare su ogni singolo gesto. Oppure alla memoria emotiva, che ci fa sentire una sensazione di fiducia o disagio verso qualcuno, anche quando non ricordiamo con precisione il perché. E poi esiste il fenomeno del priming, grazie al quale esperienze passate influenzano le nostre percezioni future senza che ne siamo pienamente consapevoli — come quando una voce o un modo di parlare ci suona familiare, anche se non riusciamo a collegarlo a un ricordo preciso.
In ambito relazionale, i diversi tipi di memoria si intrecciano dando vita a ciò che spesso chiamiamo memoria relazionale. Non è un termine tecnico nel senso stretto, ma viene usato per descrivere quella capacità di ricordare come ci siamo sentiti in relazione a qualcuno, al di là dei dettagli concreti. È un sapere silenzioso, che si attiva nelle relazioni profonde: non registriamo solo cosa è stato detto, ma tratteniamo la qualità dell’incontro, il tono emotivo, l’atmosfera.
E forse è proprio questa memoria relazionale a spiegare perché, durante una sessione, emergano dettagli che pensavamo perduti. È come se la presenza dell’altro riaccendesse tracce che la nostra mente aveva custodito in silenzio, in attesa di essere richiamate.
La memoria è molto più di un deposito di dati: è un insieme di strade, alcune illuminate dalla consapevolezza, altre percorse dall’intuizione. Quando siamo presenti e connessi — come avviene in una sessione di coaching — la nostra memoria relazionale sa guidarci, anche quando pensiamo di non sapere più nulla.
(Fonte: Treccani – Memoria)
Potrebbe interessarti anche OLTRE LE PAROLE: SCEGLIERE IL GIUSTO CANALE PER COMUNICARE EFFICACEMENTE